Bosco
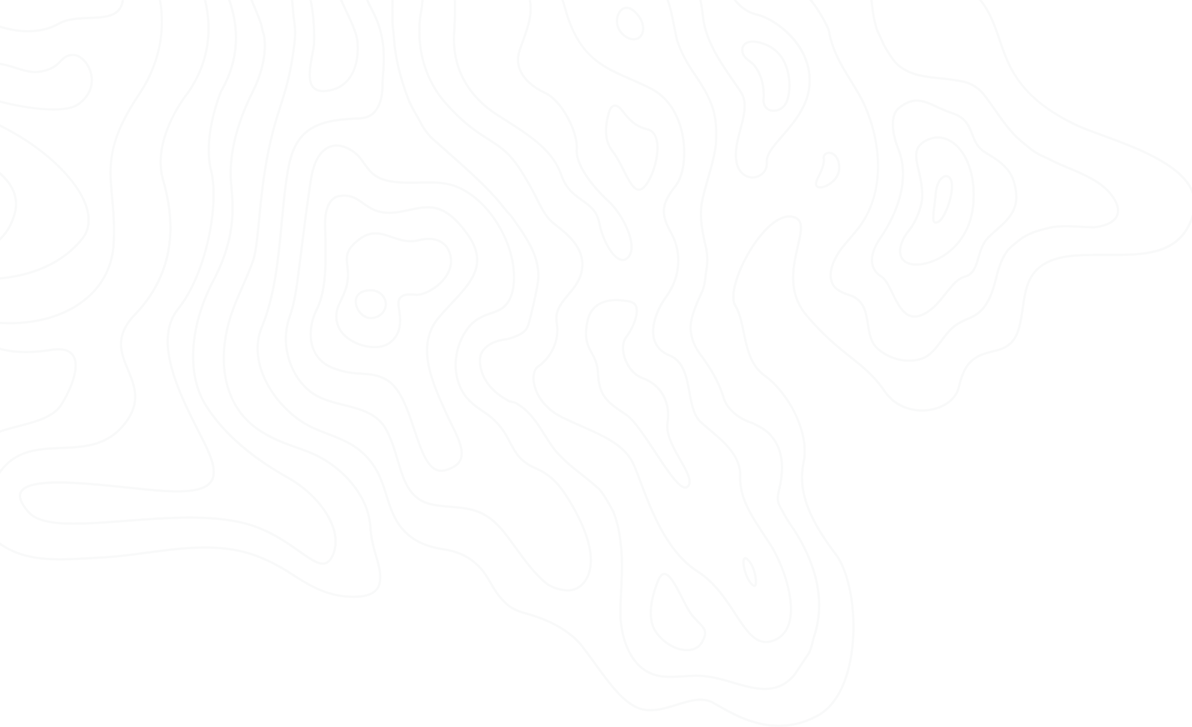

Che il territorio del Bosco di Vanzago sia stato occupato per secoli da un residuo delle grandi foreste primarie padane ce lo suggeriscono due indizi, visibili non appena il visitatore si affaccia nell’area più interna della riserva.
Il primo è la presenza di essenze come il biancospino ed il nocciolo, arbusti del sottobosco legati ad ecosistemi boschivi consolidati, che quindi inutilmente cercheremmo in boschi cedui recentemente impiantati su vecchi terreni incolti o agricoli.
Il secondo ci viene invece da grandi alberi, con un’età che supera il secolo, e che ci confermano l’antica destinazione boschiva di questo appezzamento, riportandoci a consuetudini medioevali di governo della foresta. Allora i nobili terrieri o vassalli signori di città concedevano a fittavoli e mezzadri la facoltà di taglio delle piante più piccole, riservandosi tutti i diritti sulle grandi querce, che in questo modo avevano buona possibilità di restare intatte, generazione dopo generazione.
Le farnie e le roveri di età considerevole, al bosco di Vanzago, si contano sulle dita di due mani, eppure questi pochi esemplari sono veri e propri monumenti naturali: alberi che vivevano la loro giovinezza mentre le truppe del maresciallo Radetsky manovravano nel territorio delle vicine Groane.

In altri punti del bosco invece i grandi alberi mancano, mentre si notano numerose piante giovani e vecchi ceppi seminascosti tra le foglie. Qui l’origine e la gestione delle piante è stata evidentemente di altra natura. Si tratta di ceppaie, impianti che risalgono a diversi decenni fa, operati dai proprietari, che si garantivano così la produzione d legna da ardere su vecchi terreni incolti o scarsamente produttivi.
A dominarvi è la robinia (Robinia pseudoacacia), acacia originaria del nuovo mondo, naturalizzata in Europa a partire dal 1601, che, oltre ad essere un ottimo combustibile, era in possesso di tutte le caratteristiche per svolgere il ruolo di essenza colonizzatrice: rapida nello sviluppo e molto rustica quanto a esigenza di luce e qualità del terreno. La robinia, con i suoi fusti diritti e slanciati e la leggerezza della volta verde attraverso la quale filtrano i raggi del sole, è la specie arborea più diffusa nella riserva; fortunatamente le si associano altre specie, soprattutto in quella sezione dell’oasi denominata “Sheibler”, dal nome di una casata ottocentesca proprietaria di vaste porzioni di campagna in quest’area del milanese.
E’ questa la parte più suggestiva del bosco, dove sono presenti numerosi esemplari di farnia (Quercus robur) e rovere (Quercus petraea), con esemplari di ragguardevoli dimensioni (fino a 20-25 m di altezza per quasi 1 m di diametro).
Un poco più in là nel bosco si scorgono anche alcuni castagni (Castanea sativa) radicati proprio ai margini del sentiero, mentre fra le specie introdotte figurano il pino silvestre (Pinus silvestris), l’abete rosso (Picea excelsa), più caratteristico del piano montano (ed infatti “sofferente” nell’oasi) e la quercia rossa (Quercus rubra), specie endemica del nordamerica.

Nel sottobosco risulta quasi sempre dominante il ciliegio nero (Prunus serotina), altra specie di origine nordamericana, ormai infestante in tutta la Lombardia.
L’ailanto (Ailanthus altissima) e la fitolacca (Phytolacca americana), due altre specie esotiche altamente invasive, occupano i pochi spazi rimanenti, lasciando così poche possibilità agli arbusti autoctoni, comunque presenti: il sambuco (Sambucus nigra), il biancospino (Crataegus monogyna), il nocciolo (Corylos avellana), il pado (Prunus padus), il pungitopo (Ruscus aculeatus) il tasso (Taxus baccata) e l’aghifoglio (Ilex aquifolium).
Queste due ultime specie, sempreverdi, svolgono un’importante funzione nel bosco di caducifoglie, divenendo insostituibili nel corso delle rigide notti invernali, quando il loro fitto fogliame si trasforma in rifugio per una grande varietà di piccoli passeriformi.
In effetti la scarsa varietà botanica non deve trarci in inganno perché la vita animale è molto attiva fra queste fronde: fagiani e caprioli prediligono questi tratti di bosco, tordi e merli si cibano delle bacche della fitolacca, mentre i conigli selvatici scavano le loro gallerie alla base delle ceppaie che in autunno si coprono di miriadi di funghi.
Qui, sul terreno, tra le radici del grande albero, può succedere un mattino che segue un temporale estivo, di imbattersi in una impronta un po’ particolare, piuttosto larga, con i segni delle unghie ben in evidenza, simile a quella dell’orso, ovviamente con il dovuto fattore di scala: si tratta del tasso, di tutt’altre dimensioni, ma anch’esso molto elusivo, un mustelide amante di frutta, bacche, granoturco ed invertebrati. Però non è certo il tasso l’autore dei pranzi a base di ghiande e nocciole, cibo più appropriato a dei roditori; ed infatti i segni lasciati dagli incisivi lo rivelano in modo inconfutabile: i responsabili sono il ghiro, ed il topo quercino, specie quest’ultima che, come dice il suo nome, ha una spiccata predilizione per la volta frondosa delle grandi roveri.
Più in alto tra i rami, il fringuello, il rigogolo e le cinciallegre allevano le loro nidiate. La stessa cosa fa un uccello ancora più grosso: è sufficiente alzare gli occhi per scorgere inconfondibili tra le chiome degli alberi, i grandi nidi “a cupola” della gazza e della cornacchia. Tornando invece alle piccole dimensioni, un altro interessante e “ben protetto” abitante dei boschi di latifoglie, specialmente di farnia e rovere, è il cervo volante, che nonostante le lunghe corna, è un coleottero del tutto inoffensivo.

Nel bosco a terra si incontrano poi altri piccoli tesori botanici: nonostante l’ubiquità delle essenze invasive, trovano spazio l’anemone dei boschi (Anemone nemorosa), il campanellino di primavera (Leucojum vernum), la pervinca (Vinca minor) e il sigillo di Salomone (Polygonatum multiflorum).
Si rinvengono inoltre alcune essenze adattate a terreni acidofili, come la felce aquilina (Pteridium aquilinum), la gramigna di Parnasso (Maianthemum bifolium) e il mughetto (Convallaria maialis). Quest’ultima è una piccola pianta erbacea tipica delle zone più ombrose che sa ben difendersi da possibili appetiti di animali erbivori. Malgrado il profumo soave, emanato dal piccolo fiore bianco, le foglie, i frutti e le radici del mughetto tengono lontano chiunque: tutte contengono una sostanza decisamente tossica.
Nelle fasce più aperte infine scopriamo altre specie arboree dalle dimensioni modeste, il noce (Juglans nigra), la betulla (Betula alba) ed il sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), così chiamato per i grappoli di bacche rosse invernali che gli uccellatori utilizzavano per attrarre sulle loro trappole tordi e pettirossi. Da ultimi l’acero campestre (Acer campestre) e l’acero montano (Acer pseudoplatanus), caratteristici, ancor più che per le loro foglie lobate, per gli inconfondibili frutti contenenti il seme: dei piccoli “elicotteri” che affidano la loro propagazione alla forza del vento.

Nel cuore dell’oasi è poi parte integrante del bosco un impianto di carpini bianchi (Carpinus betulus), disposti a formare tre anelli intorno ad una costruzione a forma di torre.
Anche se più che una torre la si dovrebbe chiamare rocca, o meglio “roccolo”, un antico impianto per la cattura di uccelletti tipico della Lombardia, costruito per la prima volta ad opera dei frati del convento di S. Pietro d’Orzio sui monti del bergamasco alla fine del XIV secolo. La struttura tradizionale constava di due parti: il castello e l’impianto arboreo. Il primo, era un edificio turriforme di tre piani, con l’ultimo rivestito in legno a scopo mimetico. Il piano più basso era separato ed adibito alla custodia degli uccelli da richiamo, quello intermedio costituiva la stanza da letto, il più alto per contro fungeva da locale di lavoro, dove l’uccellatore si posizionava nell’attesa degli uccelli. Elemento strutturale indispensabile a questa tecnica venatoria erano le spiaröle, delle feritoie lunghe e strette che permettevano l’avvistamento degli stormi in arrivo. Invece una feritoia più ampia permetteva di lanciare lo spauracchio, un attrezzo a forma di paletta di vimini che, imitando il sibilo delle ali di un falco in picchiata, doveva suscitare al momento opportuno il panico fra gli uccelli posati vicino al roccolo.
L’impianto arboreo era in cambio l’insieme di alberi disposti intorno al castello. La struttura era costituita da un doppio colonnato semicircolare di carpini, con le fronde intersecantesi a formare un pergolato, al di sotto del quale, fra i due filari delle colonne, si creava la “caminada”. Questo era lo spazio che ospitava la rete, invisibile. Gli alberi venivano sagomati per ricreare delle finestre naturali che dovevano sembrare agli uccelli soffermatisi nello spazio centrale del roccolo il rifugio più sicuro nell’istante del pericolo. Queste finestre però erano appunto ostruite dalla rete ed in essa incappavano gli uccelli spaventati dallo spauracchio.
Oggi pochi roccoli attivi sopravvivono in Lombardia ed in Italia: molti sono stati fortunatamente trasformati in centri di inanellamento a scopo scientifico. Il roccolo di Vanzago, dal canto suo, testimone della gestione venatoria precedente, è adesso solo la dimora sicura di ghiri, balie nere, pettirossi, sparvieri e colombacci.
Bosco WWF di Vanzago
-
Indirizzo: via Delle Tre Campane n. 21, 20043 Vanzago (MI)
Tel. CRAS 366 9765549 (numero telefonico da utilizzare esclusivamente per informazioni relative al Centro Recupero Animali Selvatici: non chiamare per altri motivi, ma utilizzare email)
Email: boscovanzago@wwf.it
